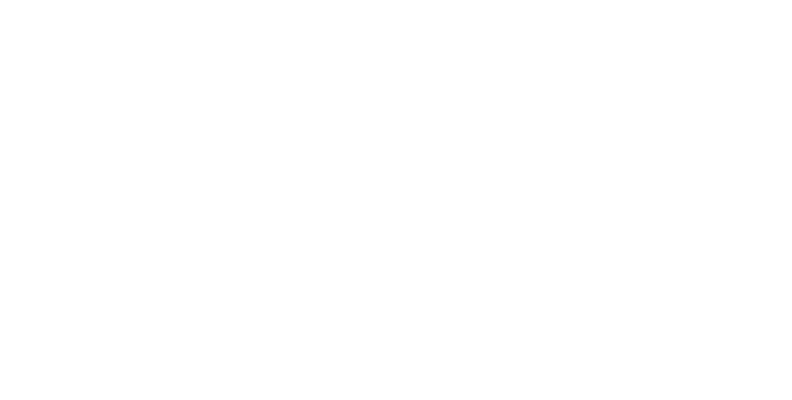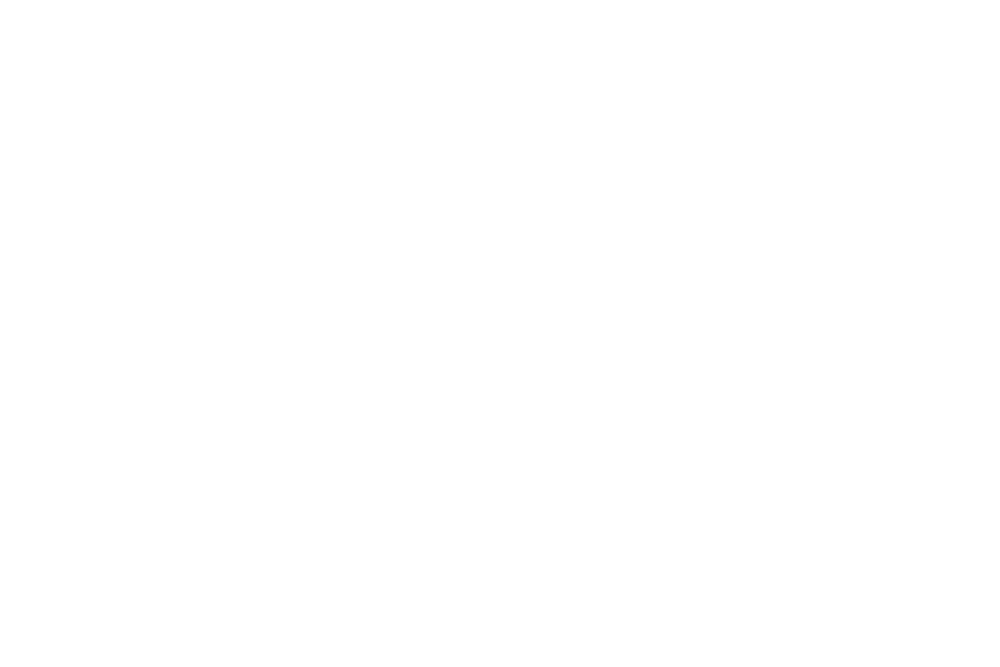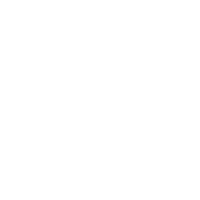Celibato sacerdotale e personalità matura
Autotrascendenza e celibato sacerdotale: Prospettiva psicologica
Introduzione
La nozione psicologica di autotrascendenza (Selbst-Transzendenz) indica la capacità essenziale dell’essere umano di uscire da sé, di superare i suoi condizionamenti interni ed esterni e dirigersi verso le realtà oggettive. È una disposizione costitutiva verso la trascendenza. Se il termine sono gli altri, sarà orizzontale; se è Dio, verticale. Si collega con la volontà di senso, quale movente dell’agire umano, che spinge alla ricerca del significato dell’esistenza. Alla luce dell’Assoluto, è un compito che ci aspetta e al quale siamo chiamati[1].
In teologia quest’idea si può trovare ovunque: si parla all’uomo che s’interroga sull’esistenza, «con la sua apertura alla verità e alla bellezza, con il suo senso del bene morale, con la sua libertà e la voce della coscienza, con la sua aspirazione all’infinito e alla felicità»[2].
L’essere umano fin da piccolo ha un potenziale di autotrascendenza, sperimenta la tensione verso l’alto come una saetta nell’arco[3]. Chi non la pone in pratica rimarrà in una falsa tranquillità, non avrà la forza della tensione per lanciarsi in avanti, e rischia il vuoto esistenziale, la mancanza di senso della vita.
In quest’articolo vogliamo studiare in che modo l’autotrascendenza si relaziona con il celibato sacerdotale. I motivi di convenienza[4] di tale carisma, la donazione a Cristo con un cuore indiviso e a tutti gli esseri umani con una paternità universale, sono di per sé autotrascendenti. Nell’essere alter Christus, in una relazione intima e personale, il sacerdote scopre la propria identità[5].
La nostra premessa è che i concetti psicologici sono insufficienti per chiarire fenomeni ben più elevati come il celibato. Se uno pensa l’uomo come un animale qualsiasi o adopera le categorie psicologiche isolate o svuotate del loro riferimento spirituale, anche le conclusioni saranno molto limitate e chiuse ad una realtà trascendente. Le esperienze dei santi arrivano più lontano, più in alto e più in profondità delle sole scienze umane[6].
Cercheremo di mostrare, con l’aiuto di alcuni psicologi aperti alla dimensione spirituale, come l’autotrascendenza sia fondamentale e serva alla piena realizzazione e alla salute dei sacerdoti celibi. La scelta dell’argomento tiene conto di articoli critici, che prendono spunto da pochi casi problematici, apparsi perfino in giornali medici[7]. Faremo qualche accenno a come sia riemerso questo concetto nella psicologia. Vedremo il rapporto con l’amore, quale manifestazione privilegiata dell’apertura dell’essere umano; e come il dono di sé può portare alla maturità.
1. Dalla psicologia del profondo all’autotrascendenza
La Psicoanalisi di Sigmund Freud (1856-1939) precisò il concetto d’inconscio e le correnti di psicologia che lo hanno seguito saranno denominate Psicologie del profondo (Tiefenpsychologie)[8]: secondo la loro concezione, la personalità è frutto di fattori biologici e ambientali, senza nessun’apertura al trascendente. Nelle profondità dell’inconscio giacciono impulsi innati, desideri, sentimenti e ricordi repressi.
La vita psichica per Freud è uno scambio costante d’energia sessuale: la libido. La volontà umana è volontà di piacere e l’amore è soltanto questa libido. L’unico stimolo dell’emotività è la ricerca dell’equilibrio, secondo il principio dell’omeostasi. L’uomo è un sistema chiuso in se stesso, preoccupato di mantenere questo suo equilibrio interno[9]. La filosofia, la morale e qualsiasi sapere superiore sono una sublimazione della libido. I due istinti basilari sono: l’istinto di morte, che porta verso l’inorganico; e l’istinto di conservazione o Eros. Liberato dalla sua repressione, l’uomo cerca di soddisfare i suoi istinti, finché si esaurisce l’energia e l’istinto di morte lo fa ritornare all’inorganico.
Alfred Adler (1870-1937), con la Psicologia Individuale, si allontana dal meccanicismo freudiano che vede soltanto cause deterministiche, e ammette nell’uomo una dimensione sociale e di autorealizzazione: la condotta è determinata da un fine, da un obiettivo. Questa meta però, altro non è che la tendenza a superare gli altri, «che si sviluppa sotto l’influsso del sentimento d’inferiorità»[10]. La finalità è intrapsichica. La tendenza non è la libido, ma lo sforzo per farsi valere, l’impulso all’autoaffermazione o la volontà di potere nel senso di Nietzsche.
Per la Psicologia Analitica di Carl Jung (1875-1961) ci sono fini e aspirazioni nel comportamento: un inconscio collettivo o memoria della specie che immagazzina archetipi. Questi archetipi sono immagini primordiali o impronte ereditate da antenati umani e animali. Ammette la possibilità di una vocazione religiosa e la domanda sul senso dell’esistenza, rimanendo però in una relazione impersonale con l’Assoluto[11].
Gli psicologi del profondo escludono ogni riferimento intenzionale trascendente. L’unico scopo psichico è l’equilibrio. Si capisce come per alcuni dei suoi seguaci il celibato sacerdotale sia «una crociata contro il padre della propria infanzia e contro gli impulsi maschili del proprio cuore (…), una pazzia, una barbarie»[12].
All’interno della psicoanalisi nasce una linea più ottimista, con autori come Abraham Maslow (1908-1970), per il quale il criterio psicodinamico più significativo è l’autorealizzazione: tutto si dirige ad essa. Su questa base, elabora una teoria dei bisogni: integrità, perfezione, onestà, fiducia, ecc. la cui frustrazione provoca la malattia psichica. Le necessità superiori si raggiungono quando sono soddisfatti i bisogni inferiori. Il rischio di tale concezione è sopravvalutare gli istinti o i bisogni: considerare l’uomo come una pianta che crescerà secondo gli stimoli che riceve dall’ambiente, escludendo la tendenza verso i valori.
Con le correnti umaniste ed esistenziali, l’apertura verso ciò che trascende il singolo è maggiore. Per Ludwig Binswanger (1881-1966) l’uomo non è isolato, ma un essere-con-l’altro che deve aprirsi ai simili: l’amore è il modo d’essere fondamentale e nocciolo della sua analisi psichica[13]. Karl Jaspers (1883-1969) sottolinea invece la realtà spirituale e considera l’esistenza stessa come trascendente: per superare la perdita del se stesso e di Dio, caratteristiche della nostra epoca, vede necessario il libero riferimento ad un trascendente, verso il quale siamo in tensione[14]. Purtroppo, per lui l’essere umano è solo nel suo naufragio; Dio è troppo lontano. Viktor von Gebsattel (1883-1973), più ottimista, mette in rilievo la trascendenza e la relazione con Dio[15]: molti problemi psichici sono più religiosi che medici, dovuti alla perdita del senso della vita e la riduzione dell’amore a sessualità.
Tra tanti altri autori, menzioniamo Gordon W. Allport (1897-1967), professore di psichiatria a Harvard. Nel suo importante studio sulla personalità[16], afferma che la mancanza di senso è più terribile dell’ansia, perché se esiste un obiettivo determinato della propria vita è possibile sopportare perfino l’angoscia e il terrore. La vita dell’essere umano non è un sistema chiuso ma aperto al mondo, capace di espandersi e di trasformarsi superando se stesso. La motivazione umana non è soltanto l’equilibrio, l’assestamento, il riposo, la soddisfazione; quindi la personalità non è solo il controllo della tensione. Tendere verso qualcosa o qualcuno al di fuori di sé non è negativo o da superare, ma essenziale alla persona.
Arriviamo al concetto di autotrascendenza, accennato da esistenzialisti come Sören Kierkegaard (1813-1855), che scrive: «misero quell’uomo che non ha mai provato l’impulso dell’amore di sacrificare tutto per amore»[17]; e sostiene che la porta della felicità si apre verso fuori: chi tenta di aprirla verso l’interno, la chiude[18].
I fenomenologi, con riferimento all’intenzionalità –la caratteristica di alcuni processi psichici di tendere verso un oggetto– danno maggior rilievo all’autotrascendenza. Lo psichiatra e filosofo austriaco Viktor Frankl (1905-1997), fondatore della Logoterapia, ha il merito di mettere al centro della psicologia la volontà di senso –ben diversa dalla volontà di piacere e dalla volontà di potere– e l’autotrascendenza, come capacità specifica della dimensione spirituale. L’essere umano è veramente umano nella misura in cui si eleva sopra la sua condizione, superandola. Quello che permette di sovrastare i condizionamenti fisici, psichici e sociali è la trascendenza: così si diventa uomo[19].
Lo psichiatra di Vienna usa un paragone: la capacità dell’occhio di percepire il mondo impedisce di vedersi. Invece, quando l’occhio è malato, ad esempio con una cataratta, vede se stesso. Nell’uomo accade qualcosa di simile: giunge ad essere pienamente se stesso nella misura in cui dimentica il proprio Io, ponendosi al servizio di una causa, dedicandosi ad un compito o ad una persona, in definitiva dando un senso alla sua vita.
C’è il rischio di prendere queste idee in senso antropocentrico, come se l’autotrascendenza fosse indirizzata verso l’uomo senza un correlato oggettivo. Così si arriverebbe ad un umanesimo autosufficiente che porta all’ateismo[20]. Ma Frankl, ebreo, ha presente la trascendenza vera, come si vede nelle sue opere e lui stesso ci confermò[21]. Dio, l’Assoluto, dà senso a tutta l’esistenza, come il punto di fuga al di fuori di un quadro permette di tracciare le linee di prospettiva. L’uomo è un essere aperto in un mondo pieno di altri esseri che bisogna incontrare e di un senso da realizzare: questa è la sua missione. L’autodeterminazione della persona spirituale deve tenere conto di un mondo oggettivo di senso e valori.
In modo simile parla l’allora Cardinale Karol Wojtyla sull’autoteleologia. L’uomo è –dice– in tensione spontanea verso il valore. È libero, ma deve scegliere fra i valori e decidere: non si chiude in se stesso, bensì si apre alla realtà; «l’autoteleologia presuppone la teleologia: l’uomo non è il confine dell’autodeterminazione, delle proprie scelte e dei propri atti di volontà, indipendentemente da tutti i valori verso i quali quelle scelte e quegli atti della volontà si rivolgono»[22]. Autoteleologia è anche autorealizzazione, le quali per essere umane implicano un’apertura verso le persone e i valori. «L’uomo realizza se stesso attraverso l’altro, raggiunge la propria perfezione vivendo per l’altro»[23].
In sintesi, la trascendenza dei valori, la presenza degli altri esseri spirituali e in particolare dell’Assoluto, dà significato alla nostra esistenza e apporta luce al celibato sacerdotale. Si supera l’antropologismo e l’esistenzialismo, sostituendoli con un’antropologia che vede una finalità e un Creatore: «o l’uomo si comprende a immagine e somiglianza di Dio, oppure si degrada a caricatura di se stesso»[24].
Le due principali manifestazioni dell’autotrascendenza sono la coscienza e l’amore. Come sarebbe impossibile un’autoteleologia senza la teleologia, così sarebbe impensabile un’autotrascendenza senza la trascendenza, senza l’altro a cui donarsi.
2. Amare, inizio del trascendere
Per spiegare il ruolo dell’amore consideriamo principalmente l’analisi che ne fa Viktor Frankl. Secondo lui amare è un atto spirituale che costituisce la relazione interpersonale più elevata e permette di conoscere la persona in se stessa. Se l’amore è genuino, saremo di fronte ad un io che ama un tu; qualcosa che sta al di sopra della semplice affettività e dei condizionamenti psicofisici, che arriva allo spirito. Ne distingue tre tipi: a) il più primitivo o sessuale, che si riferisce al corporeo; b) una forma superiore o erotica che raggiunge il livello psichico, cioè un’emotività o certi tratti di carattere che sono in grado di portare ad un innamoramento; c) in terzo luogo, l’amore vero e autentico, che consiste nell’orientamento verso la persona spirituale dell’essere amato.
L’amore radicale non si ferma, come scrisse nel suo primo libro, su quello che l’amato ha, ma su quello che è, sulla sua essenza: va oltre la fine dell’esistenza terrena ed è per sempre[25]. È l’orientamento verso l’altro in tutto quello che la sua vita ha di particolare, nella sua condizione di persona unica e irrepetibile: lo spirito si apre al mondo nella sua pienezza, alla totalità dei valori.
In queste tre forme di amore, il fondatore della Logoterapia scorge una gradazione dal piacere alla felicità. La pura soddisfazione sessuale provoca piacere come un semplice stato. L’amore erotico dà luogo alla gioia, implica una certa intenzionalità. Il vero amore porta alla felicità. Ci troviamo di fronte ad una scala d’intenzionalità: il vero amore è intenzionale, ma anche produttivo.
L’amore è pure intuitivo e ha un’importante funzione conoscitiva, perché riesce a vedere una persona nella sua singolarità. Avviene una scelta in modo particolare: la scelta di un tu. Non è una relazione anonima, originata da un Es come fonte d’impulsività o da semplici legami sociali. Si deve tornare all’amore in tutta la sua pienezza, non cosificabile, come manifestazione della relazione dell’uomo con il mondo, con le cose, con il prossimo, con Dio[26].
Quando l’amore decade, quando non c’è come obiettivo una persona, anche nella sua dimensione spirituale, degenera la volontà di senso. Tutto diventa soggettivo, con valore per me nella misura in cui sia utile. Non si aspira ad un significato o valore assoluto. Un uomo così è mosso dalla volontà di potere. E questo potere trasforma la persona in egoista. «L’io che ama –dice Frankl–, nel darsi, anzi nel donarsi al tu, prova un arricchimento interiore (…); il vero amore non rende ciechi, ma invece più capaci»[27].
Dall’amore umano si trascende al divino. A questo livello, lontano dall’immanente, si trova l’intero significato. Frankl parla di Dio come di Superpersona, capace di essere amata e di amare: l’amore perfetto come tale è anche reciproco. Possiamo dirigerci a Lui con un Tu. Così, la trascendenza assoluta, paradossalmente, si converte in intimità.
Il dono del celibato sacerdotale si spiega molto bene con queste idee sull’amore[28]. L’intenzionalità infinita dell’atto d’amore è colmata quando l’oggetto unico ed eterno, il Tu, è lo stesso Dio a cui il sacerdote si offre con un cuore indiviso e viene corrisposto. L’amore fa conoscere meglio l’Amato e si raggiunge la piena realizzazione, anche a livello biopsicosociale come rileva la psicologia[29].
3. Il celibato come realizzazione dell’autotrascendenza
Tra le caratteristiche della maturità, spicca la capacità di uscire da sé, di comprendere ed interagire con l’ambiente, con altre persone. Il bambino nel suo sviluppo si rende conto di se stesso e poi scopre il volto della mamma, degli altri, raggiungendo fiducia e autonomia. L’adolescente che supera la crisi acquista un’identità personale che gli fa cogliere il senso della sua vita e delle sue emozioni, una gerarchia di valori, un posto tra i suoi coetanei. L’adulto maturo continua quest’itinerario, esce da sé, si preoccupa degli altri, della società nel suo insieme.
Il criterio di maturità può essere il grado d’identità, come per Erik Erikson (1902-1994); o l’autorealizzazione –realizzare se stesso–, come per Maslow, ma si dovrebbero incoraggiare le caratteristiche dell’autotrascendenza. La prima di esse si può scoprire in quella che Allport chiama estensione del senso dell’Io: la persona si apre ad altri, si preoccupa del benessere dell’altro, appartiene a nuovi gruppi, nuove idee, nuove ambizioni. La vocazione personale s’introduce nel senso dell’Io. La persona matura comincia a partecipare e non soltanto ad agire: s’interessa a diversi campi e li incorpora. Così «la maturità aumenta man mano che la vita si distacca dall’imponente immediatezza del corpo e dell’egocentrismo»[30].
Le altre caratteristiche della maturità –secondo Allport– sono: il cordiale rapporto con gli altri; la sicurezza emotiva, che fa evitare reazioni eccessive riguardanti le pulsioni, tollerare le frustrazioni e tener presenti le convinzioni e i sentimenti altrui; la percezione realistica, per svolgere il proprio mestiere lasciando da parte gli impulsi egoistici e rimanendo in contatto con il mondo reale; l’auto-oggettivazione o comprensione di sé e il senso dell’umorismo –prendere distanza dalle cose e da noi– per capire meglio gli altri e aiutarli; e una concezione unificatrice della vita e del suo scopo, che permette un orientamento nei valori e di organizzare l’esistenza.
Nel cristiano, l’acquisizione di queste caratteristiche viene facilitata da un Modello. Essere maturi è un processo che ha un presupposto: «d’accordo: devi avere personalità, ma la tua deve cercare di identificarsi con Cristo»[31], scrisse san Josemaría. Logicamente i contrassegni dell’autotrascendenza devono essere presenti nel sacerdote e prendere forma nelle virtù[32]. Deve sforzarsi perché né il ministero né il dono del celibato assicurano la sua maturità.
Se uno vuole sviluppare pienamente la propria personalità, essere felice, non può guardare soltanto se stesso. Benedetto XVI scrive: «le nostre esistenze sono in profonda comunione tra loro, mediante molteplici interazioni sono concatenate una con l’altra. Nessuno vive da solo. Nessuno pecca da solo. Nessuno è salvato da solo. Continuamente entra nella mia vita quella degli altri: in ciò che penso, dico, faccio, opero. E viceversa, la mia vita entra in quella degli altri: nel male come nel bene»[33].
L’autotrascendenza matura, anche del sacerdote celibe, si manifesta in questa fiducia di non essere mai solo e nella speranza che lo fa guardare oltre le difficoltà, appoggiandosi con gran tranquillità in Dio che «ha iniziato quest’opera buona» e «la porterà a compimento» (Fil 1, 1), nonostante gli ostacoli personali e dell’ambiente. La speranza, riconducibile all’amore come ogni virtù, ci permette di avere fiducia in un significato e un aiuto trascendente, si trova radicata nell’essenza dell’essere umano, come la volontà di senso e ci dà forza e sicurezza[34].
Un pericolo grande per la maturità e per vivere bene il celibato è l’egocentrismo. L’uomo o la donna che mette il suo Io al centro di tutto non è in grado di vivere la sua esistenza come rapporto irripetibile con Dio e con la sua creazione. L’egocentrismo è legato all’egoismo, del quale san Tommaso scrisse: «manifestum est quod inordinatus amor sui est causa omnis peccati»[35]. Abbiamo questa tendenza per il peccato originale, e si può accentuare quando nell’educazione il bambino è posto al centro di tutto[36].
L’amore inteso in chiave egocentrica provoca sofferenza e può far fallire sia il matrimonio sia l’impegno di corrispondere al dono del celibato. Ogni amore vero arricchisce chi ama, ma non rimane nel soggetto, comporta donazione, sacrificio per la persona amata. L’amore umano non è un semplice istinto di conservazione della specie né un mezzo indirizzato al piacere sessuale. Quando manca la virtù, quando si guarda troppo il piacere o la corporalità –in sé buona– si rischia di rovinare l’amore e perfino il piacere, dando luogo a malattie psichiche e deviazioni[37]. L’autotrascendenza si compromette, si «tagliano le ali dello spirito»[38], come afferma Heinz Remplein (n. 1914).
Alcuni non capiscono il celibato proprio perché parlano di amore come sinonimo di sessualità. Quando l’amore non è genuino, autotrascendente, resta fermo nell’espressione di se stesso e si prova solitudine: si cercano relazioni d’intimità che deviano in promiscuità. Il vero amore crea delle unioni, la mera sessualità le distrugge: «ogni autentico movimento d’amore eleva»[39].
Chi vive il celibato non è immune da una fissazione egocentrica, ma se si sforza ogni giorno per far crescere l’amore di Dio, che ispira e sostiene la sua castità[40], come una persona impegnata e non come scapolo, con la grazia, potrà perseverare nel dono. I problemi cominciano quando si raffredda l’amore, si perde di vista la meta, Gesù, si chiudono gli occhi alla trascendenza e si rivolgono all’Io.
Nei candidati al sacerdozio, anche per ravvivare in loro il desiderio di vivere con fedeltà il celibato, si deve esaminare la capacità di autotrascendenza, manifestata tra l’altro nella virtù della castità –amore vero–, la rettitudine d’intenzione e l’oblio di sé. Si deve favorire una sana educazione dell’amore: il cuore deve imparare ad amare[41]. Come affermò Vallejo-Nágera, noto psichiatra spagnolo: «l’educazione alla castità è molto salutare e ci ha aiutato tantissimo a superare i problemi legati all’età. Invece la presunta libertà sessuale che si predica adesso, certamente riempie le sale d’aspetto degli psichiatri»[42].
La maturità affettiva di coloro che desiderano vivere il celibato implica la coscienza del posto centrale dell’amore nell’esistenza umana[43], e la libertà psicologica che permette di uscire da sé, di trascendersi e trovare una piena soddisfazione. Il sacerdote celibe deve avere una relazione interpersonale matura; in qualche modo sarà simile alla relazione paterno-filiale e a quella dell’aiuto professionale[44], per diventare padre di tutti, medico e pastore.
Studi psicologici recenti, come quelli di Cloninger, confermano l’importanza, anche per il benessere psicosociale, dell’autotrascendenza, del lavoro a servizio degli altri e della ricerca di un senso spirituale. La persona, per essere felice, deve superare l’immaturità e raggiungere una coscienza di sé più trascendente. L’uomo passa da uno stato infantile, dalla gratificazione immediata, ad uno adulto che non può rimanere egocentrico[45].
Conclusioni
L’autotrascendenza è un concetto valido per illuminare alcuni segni caratteristici della vita sacerdotale. Essendo essenziale a qualsiasi persona, diventa ancora più importante e urgente nel sacerdote, che deve rivolgersi a Dio con un amore vero ed effettivo per servire gli altri. Il celibato propter regnum caelorum (Mt 19, 12) non rende l’uomo meno capace di uscire da sé, ma al contrario, lo stimola in quella direzione. La maturità personale e la propria identità del sacerdote si rafforzano. La piena autotrascendenza e l’autentica autorealizzazione sono possibili perché Dio è indubbiamente in grado di colmare le necessità del cuore, di riempirlo di senso.
Il celibato inoltre è un modo di testimoniare l’apertura universale dell’amore di Gesù Cristo. Così parlava Giovanni Paolo II ai presbiteri: «ci rendiamo conto che il “realizzare se stessi” nella vita ha un riferimento ed un fine trascendenti, contenuti nel concetto di “gloria di Dio”: la nostra vita è chiamata a diventare officium laudis»[46]. E avvertiva i medici: «nessuna adeguata stima dell’uomo o dei requisiti per il compimento umano e il benessere psico-sociale possono essere fatti senza rispetto per la dimensione spirituale e capacità per l’autotrascendenza»[47].
L’autotrascendenza è indispensabile per mantenere l’equilibrio e la salute fisica, psichica e spirituale. La vita matrimoniale o l’uso della facoltà riproduttiva non sono invece imprescindibili. L’uomo non è spinto soltanto da forze cieche, profonde, ma è anche attirato da realtà che stanno al di fuori di lui: il senso, i valori, le altre persone, Dio. Per questo l’egocentrismo è un rischio serio.
Il celibato sacerdotale non limita l’affettività umana ma richiede maturità: una «scelta di libertà e accoglienza grata di una particolare vocazione di amore per Dio e per gli uomini»[48]. Anche se la grazia è sempre efficace, e Dio può guarire ogni deficienza, non è meno vero che Lui conta sulla collaborazione dell’uomo, perciò bisogna conoscere la psicologia dei candidati[49] e sviluppare l’autotrascendenza, come una vera interiorità aperta.
Per riuscire a vivere il celibato è necessario lasciarsi prendere da un Dio personale. Un Dio che corrisponde all’amore ed è l’artefice della nostra autotrascendenza. Si vede qui una significativa differenza con il celibato che si pratica in alcune religioni orientali, in cui è l’uomo stesso il promotore e realizzatore. Il sacerdote, invece, è stato preso dagli uomini, homo ex hominibus assumptus (Ebr 5, 1), come servitore dei suoi fratelli[50].
Rimangono molti temi da approfondire: il sacrificio e l’autodonazione di Cristo[51], la formazione nei seminari, la perseveranza nella decisione definitiva al celibato, ecc. Sarà sempre l’amore –inizio del trascendere– la forza e l’unico modo per mantenere o ritrovare la strada, se è stata persa o danneggiata[52].
Il concetto di autotrascendenza, insomma, ci aiuta a capire l’adeguatezza del celibato per i presbiteri, che cercano di essere «un’immagine viva e trasparente di Cristo sacerdote»[53]. Senza la fede s’intenderà poco questa trasparenza. La storia delle eresie conferma che «se la fede si raffredda, diminuisce anche la forza per perseverare; dove muore la fede, muore anche la continenza»[54].
A giustificare il celibato dunque non basta la psicologia né altra scienza umana. Serve elevarsi al di sopra di questo mondo. Solo chi riconosce il desiderio di trascendenza, può comprendere che ci siano uomini disposti a seguire da vicino il Modello e ammirare il dono che ricevono. Chi non è in grado di apprezzarlo è come chi non capisce una sinfonia perché, con parole di Chesterton, «non ha orecchio per la musica»[55].
Persino coloro che non si considerano credenti sperimentano –spesso inconsciamente– la tensione verso l’alto. Alcuni, con la grazia di Dio, scoprono l’Assoluto; altri rimangono legati al mondo materiale, dentro di sé, all’oscuro. Tutti però siamo alla ricerca del senso della vita, con un’assetata speranza d’autotrascendenza, che s’intravede in questi versi:
«Muore la pianta e di nuovo si sotterra,
tornano i piedi dell’uomo al territorio,
solo le ali sfuggono alla morte.
Il mondo è una sfera di cristallo,
l’uomo è perduto se non vola:
non può comprendere la trasparenza»[56].
Wenceslao Vial Mena
Citare come: «Autotrascendenza e celibato sacerdotale: prospettiva psicologica», en L. Touze, y M. Arroyo, (eds.), Il celibato sacerdotale. Teologia e vita, ESC, Roma 2012, 289-302.
[1] Cfr. Russo, F., «La spiritualità della persona come autotrascendenza», Acta Philosophica, III/1 (1994), pp. 127-133. Si relaziona con l’autoteleologia nel piano dell’operare e l’intenzionalità, nell’ambito conoscitivo fenomenologico. È analizzata nella psicologia clinica e in alcuni test di personalità, come il Temperament and Character Inventory (TCI), di Cloninger.
[2] Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 33, 1.
[3] Cfr. S. Agostino, De Civitate Dei, XIII, 3.
[4] Cfr. Cfr. Concilio Vaticano II, Presbyterorum ordinis, n. 16; Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, 31 gennaio 1994, n. 58; Herranz, J., «Sacerdozio ministeriale e legge del celibato», Studi Cattolici, 328/XXII (1988), pp. 367-369.
[5] Cfr. Sepe, C. Attualità del celibato sacerdotale, in AA.VV., Solo per amore. Riflessioni sul celibato sacerdotale, Edizioni Paoline, Milano 1993, pp. 60-75.
[6] Torelló, J.B., Las ciencias humanas ante el celibato sacerdotal, in Lorda, J.L., (editore), El celibato sacerdotal. Espiritualidad, disciplina y formación de las vocaciones al sacerdocio, Eunsa, Astrolabio, Pamplona 2006, pp. 191-206.
[7] Cfr. Delamothe, T., «Catholic priests: is better to marry than to burn (and beat up)», in British Medical Journal 338/b2142 (maggio 2009): considera in modo parziale i tristi casi di abuso sessuale in Irlanda, in scuole e residenze cattoliche, come se il celibato ne fosse il motivo.
[8] Cfr. Lersch, P., La estructura de la personalidad (Aufbau der Person), Scientia, Barcelona, 1966, pp. 584-585.
[9] Cfr. Freud, S. Compendio della Psicoanalisi (Abriss der Psychoanalyse, 1938).
[10] Adler, A., Conocimiento del hombre, Espasa Calpe, Madrid 1968, p. 67.
[11] Cfr. Jung, C., Realidad del alma (Wirklichkeit der Seele), Losada, Buenos Aires, 1957, pp. 161-173.
[12] Drewermann, E. cit. da Torelló, J.B., Las ciencias humanas, cit., pp. 191-206. Eugen Drewermann (n. 1940), ex sacerdote, tedesco, abbracciò la psicologia del profondo.
[13] Cfr. Binswanger, L., La psichiatria come scienza dell’uomo (Der Mensch in der Psychiatrie), Ponte alle grazie, Firenze 1992.
[14] Cfr. Jaspers K., Filosofía de la existencia (Existenzphilosophie), Madrid, 1961.
[15] Cfr. von Gebsattel, V.F., Antropología médica (Prolegomena einer medizinischen Anthropologie), Rialp, Madrid 1966.
[16] Cfr. Allport, G., Psicologia della personalità (Pattern and Growth in Personality), Pas-Verlag Zürich, Roma 1969, pp. 469-482.
[17] Kierkegaard, S. “La Malattia Mortale. Saggio di psicologia cristiana per edificazione e risveglio di Anti-Climacus”, in Kierkegaard, S., Opere, Sansoni, Firenze, 1972 (pp. 619-692), p. 689-690.
[18] Cit. da Frankl in Senso e valori per l’esistenza (The will to meaning), Città Nuova, Roma 1994, p. 147.
[19] Cfr. Frankl, V., Kreuzer, F., In principio era il senso. Dalla psicoanalisi alla logoterapia (Im Anfang war der Sinn. Von der Psychoanalyse zur Logotherapie), Queriniana, Brescia 1995, p. 102.
[20] Cfr. Rulla, L.M., Antropologia della vocazione cristiana, vol. 1: Basi interdisciplinari, PIEMME, Casale Monferato, 1986, pp. 186-189.
[21] Cfr. Vial, W., La antropología de Viktor Frankl, Editorial Universitaria, Santiago de Chile 2000, pp. 317-321. Per le differenze con le teorie dell’incontro di Martin Buber (1878-1965), non aperto alla trascendenza verticale: pp. 70-72.
[22] Wojtyla, K., Perché l’uomo. Scritti inediti di antropologia filosofica, Leonardo, Milano 1995, p. 142; vedere: Trascendenza della persona nell’agire e autoteleologia dell’uomo, pp. 137-152.
[23] Ibidem, p. 148.
[24] Frankl, V., Homo Patiens. Soffrire con dignità (Homo Patiens. Versuch einer Pathodize), Queriniana, Brescia 2001, p. 113.
[25] Cfr. Frankl, V., Logoterapia e analisi esistenziale (Ärztliche Seelsorge), Morcelliana, Brescia 1972, pp. 193-196.
[26] Cfr. Torelló, J.B., Psicología abierta, Rialp, Madrid 1972, pp. 89-95.
[27] Frankl, V., Logoterapia e analisi esistenziale, cit., p. 165.
[28] Cfr. Frankl, V., Torelló, J.B., Wright, J., Sacerdozio e senso della vita, Ares, Milano 1970.
[29] Cfr. Zapata, R., Celibato y madurez psicosexual y afectiva, in El celibato, cit., pp. 81-103.
[30] Allport, G. Psicologia della personalità, cit., p. 243; cfr. pp. 241-260.
[31] Escrivá de Balaguer, J. San, Forgia, n. 468; cfr. È Gesù che passa, n. 31.
[32] Cfr. Vaticano II, Optatam Totius, n. 11.
[33] Benedetto XVI, Spe salvi, n. 48.
[34] Cfr. Torelló, J.B., «Sapienza e follia della croce», in Studi Cattolici, n. 439, anno XLI (1997), pp. 580-584.
[35] Tommaso d’aquino, San, S.Theol., I-II, q. 77, a 4.
[36] Per egocentrismo, cfr. Torelló J.B., Psicología y vida espiritual, Rialp, Madrid 2008, pp. 110-127.
[37] Cfr. Frankl, V., Psicoterapia nella pratica medica (Die Psychotherapie in der Praxis), Giunti-Barbera, Firenze, 1968, pp. 45-98. Sono frequenti le disfunzioni sessuali, le parafilie, come la pedofilia e altre fissazioni su oggetti sessuali inadeguati, diversi dalla complementarietà naturale dell’uomo e della donna, l’autoerotismo o l’omosessualità.
[38] Remplein, H., Tratado de psicología evolutiva. El niño, el joven y el adolescente (Die Seelische Entwicklung des Menschen in Kindes und Jugendalter), Labor, Barcelona 1971, p. 564.
[39] von Gebsattel, V.F., Antropología médica, cit. p. 382; cfr. pp. 374-390.
[40] Cfr. Soria, J.L., Questioni di medicina pastorale, Japadre, L’Aquila 1969, p. 222.
[41] Cfr. Monge, M.A., La formación de las vocaciones al celibato, in El celibato, cit., pp. 41-58.
[42] Olaizola, J.L., Vallejo- Nágera, J.A., La puerta de la esperanza, Planeta, Barcelona 1992, p. 64.
[43] Cfr. Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, (25 marzo 1992), n. 44.
[44] Cfr. Zapata, R., Celibato y madurez psicosexual y afectiva, cit., pp. 99-102.
[45] Cloninger, R., «The science of well-being: an integrated approach to mental health and its disorders», in World Psychiatry, 5:2, giugno 2006, pp. 71-76.
[46] Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti il giovedì santo, 17 marzo 1996, n. 6.
[47] Giovanni Paolo II, Discorso ai membri dell’American Psychiatric Association, 4 gennaio 1993 in Insegnamenti XVI, 1, pp. 13-15 (orig. inglese; trad. italiana in www.vatican.va).
[48] Cfr. Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, cit., n. 59.
[49] Cfr. Congregazione per l’Educazione Cattolica, Orientamenti per l’utilizzo delle competenze psicologiche nell’ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio, 30 ottobre 2008.
[50] Cfr. Del Portillo, A., El celibato sacerdotal en el Decreto Presbyterorum ordinis, in El celibato, cit., pp. 107-127: apparso in Palabra, N° 32, aprile 1968.
[51] Il sacerdote celibe rispecchia meglio quella suprema autodonazione: cfr. Goyret, P., Prospettiva dogmatica del celibato sacerdotale: fra memoria e attesa; in Sacerdozio e celibato nella Chiesa, Centro ambrosiano, Milano 2007, pp. 133-148.
[52] Cfr. Benedetto XVI, Gesù di Nazaret (Jesus von Nazareth – Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung), Rizzoli, Milano 2007, p. 212.
[53] Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, n. 12.
[54] Stickler, A.M., El celibato eclesiástico: su historia y sus fundamentos teológicos, in El celibato, cit., pp. 129-189, p. 156.
[55] Chesterton, G.K., Orthodoxy, Doubleday, New York 2001, pp. 165-166.
[56] Neruda, P., El vuelo, in Arte de pájaros, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2004, pp. 50-52.