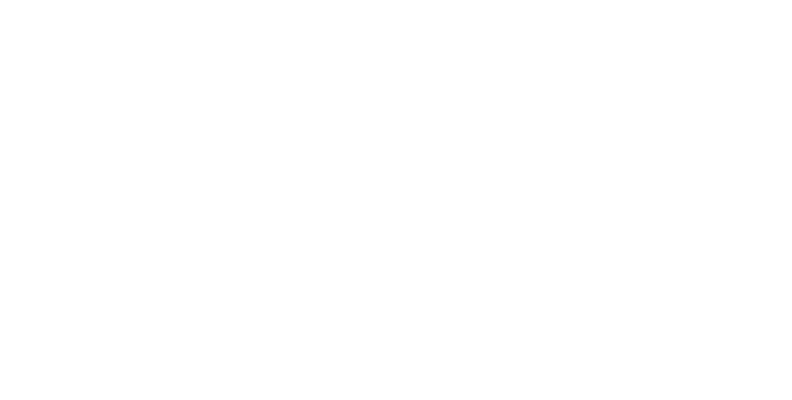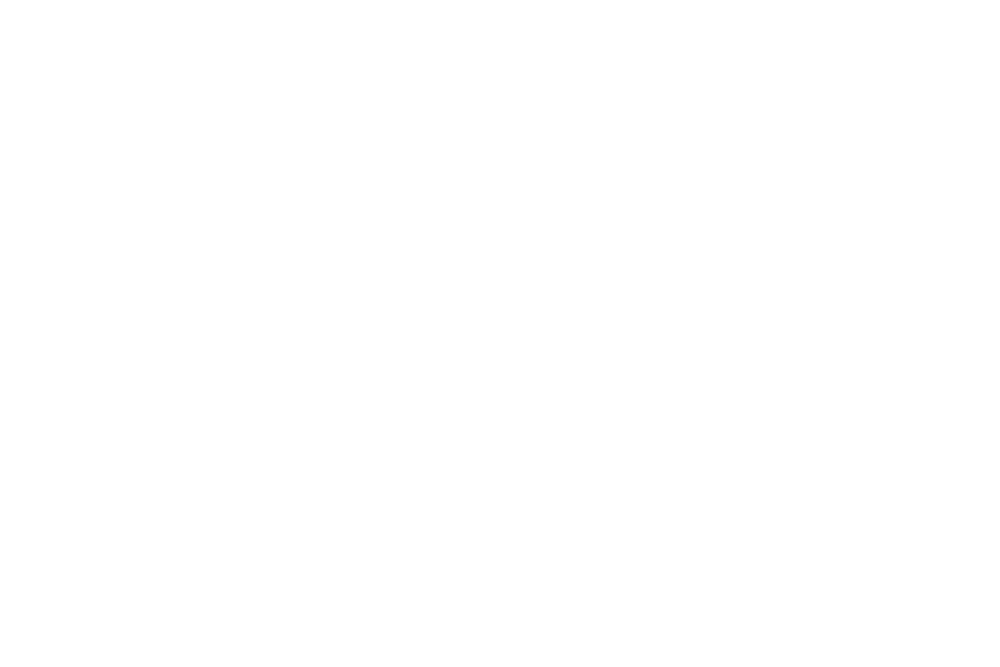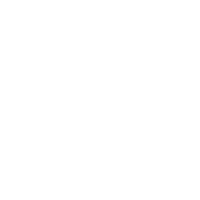Giovanni Paolo II formazione e virtù
Il bisogno di formare alla virtù
Discorso di san Giovanni Paolo II ai professori e agli alunni della pontificia università San Tommaso D’Aquino Giovedì, 24 novembre 1994.
Cari Religiosi, Insegnanti ed Alunni dell’Angelicum!
1. Sono lieto di trovarmi per la seconda volta in mezzo a voi, in questa Università che anch’io, da giovane, ho frequentato. Rivolgo un cordiale saluto al Gran Cancelliere, P. Timothy Radcliffe, che ringrazio per le gentili parole di benvenuto, al Magnifico Rettore, ai docenti ed agli studenti, mentre con pensiero affettuoso intendo altresì raggiungere, da questo prestigioso centro di studi, i membri dell’intera Famiglia domenicana.
Alle soglie del terzo millennio, guardando alle gloriose tradizioni di santità e di cultura dei Frati Predicatori, recentemente richiamate dalle beatificazioni del P. Hyacinthe-Marie Cormier, Generale dell’Ordine e fondatore del Nuovo Collegio Angelico e di due religiose della stessa Famiglia, Suor Marie Poussepin e Suor Agnès de Jésus Galand de Langeac, vorrei ripercorrere con voi le tappe del grande contributo all’evangelizzazione dato dai figli di San Domenico, per soffermarmi su ciò che oggi essi sono chiamati ad offrire alla Chiesa e al mondo nell’impegno della nuova evangelizzazione.
2. La fiorente vitalità dell’Ordine si è maggiormente espressa, lungo la storia, quando ha più intensamente condiviso l’appartenenza alla Chiesa e la partecipazione alla sua missione. San Domenico, “vir qui vivit in medio Ecclesiae”, ha posto al centro della vostra Regola il carisma dell’evangelizzazione, l’Uffizio del Verbo, come dirà Santa Caterina da Siena, scegliendo per i suoi confratelli la vita degli Apostoli: “Nos oportet orationi et ministerio verbi intentos esse” (At 6, 4), in piena a costante obbedienza ai Successori di Pietro.
Mi piace evocare in particolare tre fasi salienti, in cui il carisma dell’evangelizzazione è stato vissuto dal vostro Ordine con particolare impegno: l’ardore missionario degli inizi verso i popoli dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia; l’annuncio evangelico nelle terre del nuovo Continente durante il secolo sedicesimo; lo slancio apostolico dell’Ordine in Francia dopo la rivoluzione, ad opera specialmente del P. Lacordaire e, in seguito, del P. Cormier.
Il servizio reso dall’Ordine dei Predicatori all’opera missionaria nel secolo tredicesimo è davvero singolare. Con gli Ordini Mendicanti, infatti, la Chiesa organizzò in modo consistente le missioni “ad gentes”, oltre i confini del mondo conosciuto. Il Vangelo venne annunziato non soltanto in tutti i paesi dell’area mediterranea, ma fu portato anche in tanti paesi dell’estremo Oriente.
Fin da allora iniziò il dialogo con l’Islam e si approfondì quello con gli Ebrei. Se a questo slancio missionario, si aggiunge lo sforzo dei teologi domenicani per promuovere il servizio della catechesi, abbiamo un panorama completo dell’opera d’inculturazione del Vangelo intrapresa in modo esemplare nel secolo tredicesimo con il valido apporto del carisma domenicano.
In occasione del V Centenario dell’Evangelizzazione dell’America è stato opportunamente ricordato il prezioso contributo dato in quell’occasione alla causa del Vangelo dalla Famiglia domenicana. Lo testimoniano figure luminose quali Antonio Montesinos, Pedro di Cordova, Bartolomeo de Las Casas e Juan Solano, Vescovo di Cuzco, che nel 1575, presso Santa Maria sopra Minerva, fondò il Collegio di San Tommaso per rispondere alle sfide dell’inculturazione.
Dopo le ferite della Rivoluzione francese, la rinascita dell’Ordine vide la ripresa dell’osservanza regolare e il ritorno allo studio e all’apostolato specialmente ad opera del P. Lacordaire. Successivamente, con il sostegno e l’incoraggiamento del Papa San Pio X, il P. Cormier svolse un ruolo decisivo per il rilancio del carisma domenicano nel secolo ventesimo. Con fedeltà e amore alla Chiesa, egli promosse l’impegno dell’evangelizzazione fondando a tal fine il Nuovo Collegio Angelico a Roma e sostenendo con forza la Facoltà di Teologia di Friburgo, come pure la nascente Scuola Biblica di Gerusalemme.
Di questa fecondità del rinnovato carisma domenicano sono splendido esempio anche le due religiose della vostra Famiglia, che ho avuto la gioia di elevare all’onore degli altari. È noto, infatti, l’impegno nell’America Latina delle Suore domenicane della Presentazione, fondate da Marie Poussepin e la carica di ardore apostolico lasciato da Suor Agnès de Jésus Galand de Langeac, madre spirituale ed ispiratrice del fondatore dei Sulpiziani.
3. Su tale scia si colloca l’attuale vostro impegno nella nuova evangelizzazione. Si tratta di alimentare la fiaccola dell’annuncio cristiano nel contesto di una opportuna inculturazione della fede. Gli apostoli della nostra epoca hanno davanti uno scenario ben diverso da quelli del passato e dispongono di inedite e ben più idonee risorse culturali e scientifiche. Ma nel momento del passaggio dal secondo al terzo millennio è forte la consapevolezza della crisi della cultura moderna, come pure la coscienza delle responsabilità dei cristiani nell’attuale contesto. Compito senz’altro arduo che pone i credenti, in maniera particolare, di fronte a tre grandi categorie di uomini in difficoltà: coloro che ancora non credono, coloro che sono nati nel contesto di popoli cristiani tra i più fedeli, ma che oggi non credono più, e coloro che, avendo il dono della fede, non sono in grado di conformare la propria vita al Vangelo. Davanti a tale realtà la nuova evangelizzazione impone un nuovo slancio missionario per risvegliare le coscienze, orientandole verso Cristo, Redentore dell’uomo.
Cari Padri Domenicani, ecco il vostro compito: prendete parte attiva alla nuova evangelizzazione! Il vostro carisma di studio della parola di Dio e delle realtà umane può prestare un valido servizio oggi, come avvenne nel passato. La fedeltà al carisma vi sollecita alla approfondita comprensione della realtà culturale del presente, alla denuncia profetica delle deviazioni intellettuali e morali, e all’inculturazione della fede.
4. Una lettura cristiana della presente situazione culturale non può non percepirne la crisi profonda, che è soprattutto crisi della ragione. Molti, oggi, sono portati a riconoscere soltanto il ruolo strumentale della ragione, in ordine alla comprensione scientifica della realtà e all’applicazione tecnologica dei suoi risultati, escludendo dalla sua competenza la dimensione morale e quella trascendente. In tal modo l’uomo corre il rischio di rinunciare sempre più al compito della ragione in quanto intelligenza, privandosi delle possibilità di arrivare alla trascendenza, e di proporre verità assolute, fini, valori e norme di carattere incondizionato, postulati dalla legge morale naturale, come ho sottolineato nell’enciclica Veritatis splendor. Di fronte a questo smarrimento del ruolo dell’intelligenza, il carisma domenicano deve ritrovare la sua vocazione all’approfondimento della verità, dell’assoluto, delle ragioni stesse della vita.
L’uomo del nostro tempo somiglia molto al malcapitato viandante di cui si parla nella parabola del buon Samaritano (cf. Lc 10, 30-37): è spogliato, percosso e ferito; deve pertanto ritrovare Dio, suo fondamento, principio e fine.
Ancorato al reale e alla ricerca della trascendenza, il vostro carisma profetico non può conformarsi alla mentalità di questo secolo, secondo l’ammonimento dell’apostolo Paolo (cf. Rm 12, 2). Dovete riproporre con forza anche oggi il primato di Dio e la testimonianza del mistero di Cristo, la fedeltà alla Chiesa (cf. Giovanni Poalo II, Discorso ai Capitolari dei Frati Predicatori, 5 settembre 1983, : Insegnamenti di Giovanni Poalo II, VI, 2 (1983) 387-393). Siete chiamati a mettere al servizio del nostro tempo tale vostra preziosa eredità carismatica.
In particolare, Tommaso d’Aquino, che ben può essere detto “Doctor humanitatis” per la sua dedizione appassionata alla verità e per il valore della sua antropologia e della sua metafisica, deve diventare per voi modello di dialogo con la cultura del nostro tempo. Attento alla verità e all’amore per l’uomo, egli ricorda alla cultura teologica del nostro tempo la vigilanza nei confronti delle deviazioni della cultura moderna. La sua fiducia nel potere della verità incoraggia ad assumere il duplice compito di ricerca della verità e di denuncia degli errori. Compito che voi già adempite efficacemente in questa Università e negli Istituti ad essa collegati.
5. Carissimi Fratelli! Carisma dei Frati Predicatori è di annunciare il Salvatore, proclamare a tutti gli uomini la salvezza in Gesù Cristo, Vangelo del Padre. San Domenico l’ha imparato dall’apostolo Paolo, le cui lettere egli portava sempre con sé, vicino al cuore. Accanto però a tale missione il domenicano è chiamato a penetrare nei misteri di Cristo mediante la preghiera, particolarmente con il Rosario. L’orazione, infatti, fa esercitare in modo sublime l’ufficio di ponte culturale tra Dio e gli uomini del nostro tempo.
Alla luce dell’eredità del vostro carisma di evangelizzatori e dell’urgenza della sua proiezione nel nostro contesto culturale, risalta l’importanza del tema del Congresso, che avete recentemente celebrato, centrandolo sulla formazione. Chiamati a vivere sui due versanti della contemplazione e della comunicazione delle verità contemplate, “contemplari et contemplata aliis tradere” (Sant’Agostino, Summa theologiae, II-II, 186, 6), è vostro compito fare della formazione dei futuri evangelizzatori uno degli obiettivi primari del vostro impegno nel mondo d’oggi.
Con l’ausilio della solida dottrina di San Tommaso, il processo della formazione deve seguire le inclinazioni al bene della natura, per arrivare alla disponibilità alla grazia dello Spirito Santo, così che la personalità dell’evangelizzatore domenicano sia, da una parte, effetto dei doni di Dio, autore della natura e datore della Grazia e, dall’altra, risultato dell’impegno della persona stessa.
Non si tratta tanto di assumere elementi esterni, ma di sviluppare armonicamente ogni potenzialità già presente nella natura umana. La formazione dell’uomo, infatti, consiste nello sviluppo delle proprie capacità, nella formazione della propria libertà mediante la quale dispone di se stesso (cf. Tommaso, Quaestiones disputatae: “De Magistro”, 11).
Occorre poi promuovere la maturazione della persona, aiutandola a sviluppare le sue dimensioni socio-culturali, morali, religiose mediante l’uso retto della libertà. La formazione unitaria della personalità umana non può non tendere alla crescita integrale nelle sue relazioni col mondo, con gli altri, e principalmente con Dio. Egli solo è Buono (cf. Mt 19, 17). Questo implica innanzitutto, come ricorda San Tommaso, la formazione etica che ha il primato nella formazione integrale della persona.
6. Nella perfezione cristiana, inoltre, elementi decisivi sono la grazia e i doni dello Spirito Santo, che viene in aiuto dell’uomo debole e peccatore. La formazione del predicatore è opera della grazia, la quale eleva la natura, infonde le virtù teologali, e rende l’attività dell’uomo capace di tendere a Dio come è in Se stesso. L’uomo perfetto è colui che si conforma a Gesù Cristo, l’uomo in pienezza.
Carissimi, è questa la vostra grande missione: la formazione iniziale e permanente, sotto l’influsso della grazia di Dio e mediante la luce e la forza dello Spirito. Dal mistero trinitario stesso scaturisce la forza della vostra spiritualità, capace di offrire la “forma mentis et cordis” dell’autentico evangelizzatore per il nostro tempo.
A Maria, Regina degli Apostoli, affido le vostre fatiche, affinché sia Lei a camminare al vostro fianco, in modo che sappiate portare con letizia e forza all’uomo d’oggi l’annuncio vivificante del Vangelo.
Con tali auspici, imparto a tutti la benedizione apostolica.
Fonte: vatican.va