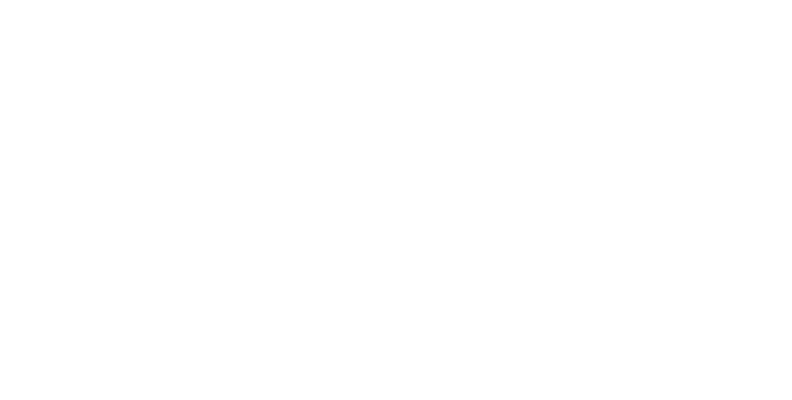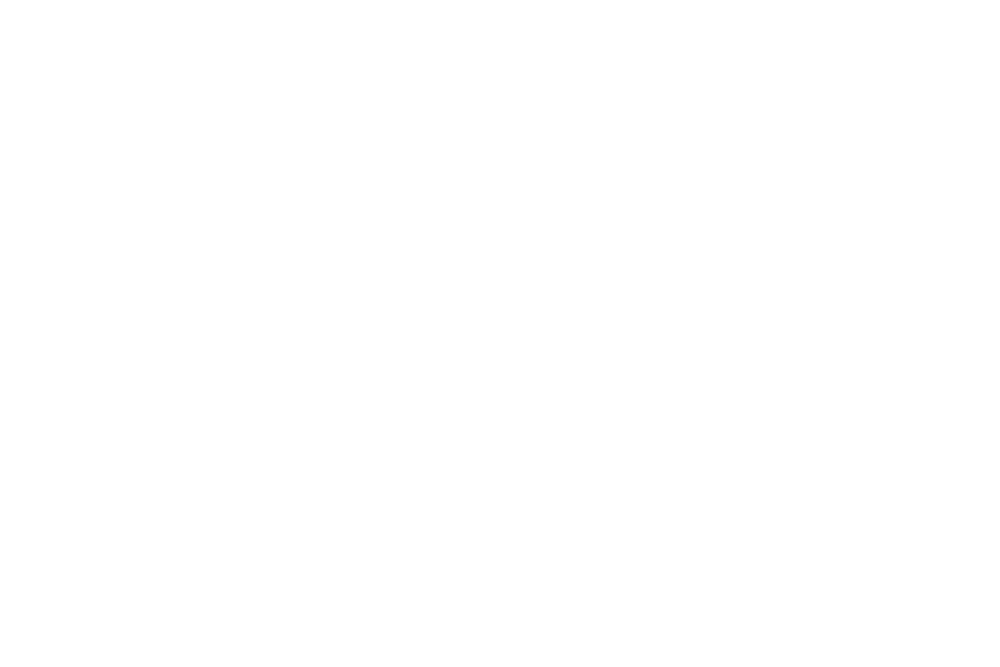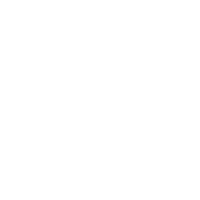Voler essere amato. L’avventura dell’amore
Vivere e insegnare l’avventura dell’amore
Formazione dell’affettività per l’avventura di voler amare ed essere amati. Imparare ad amare per essere in sintonia con Dio, con gli altri e con il mondo. Avere una bussola per amare. Capitolo del libro Amare e insegnare ad amare.
Paul O’Callaghan, esperto in teologia e antropologia, approfondisce l’arte di amare e di saper aspettare per vivere felicemente e rispondere pienamente, sia nel celibato che nella vita matrimoniale. Descrive un’affettività sana che sa dare un nome a ciò che sente.
Indice del contenuto voler l’avventura dell’amore
- Amare ed essere amato
- Alcune difficoltà nell’avventura dell’amore
- La chiave dell’amore
- Una dinamica di gratificazione differita nel vero amore
- Educare per godere l’avventura dell’amore
1. Amare ed essere amato
Tutti vogliono essere amati. L’essere apprezzati e amati dagli altri riempie il cuore di compiacimento, pace, felicità, coraggio, grandi desideri, energia, benessere. L’essere amato trova una profonda risonanza nello spirito umano. Colui che è amato si sente riconosciuto, stimato, dignificato, rispettato, con una identità consolidata.
Ma non tutti sono disposti ad amare, ad amare in modo efficace, sacrificato, perseverante e generoso. Amati, sì, tutti; ma amare, non così tanto! E lì cominciano i problemi. Perché se le persone amano di meno perché non sono amate a loro volta, i potenziali destinatari di quell’amore si sentiranno meno amati, forse delusi. . . e quindi meno disposti a corrispondere a ciò che hanno ricevuto. Si tratta di una specie di “circolo vizioso” con cui si finisce per amare sempre meno.
L’amore per il prossimo non è opzionale
Per il cristiano, lo sappiamo bene, l’amore per il prossimo non è opzionale. È semplicemente essenziale per la sua vita. È il comandamento del Signore. Al punto che, senza di esso, non è possibile dire che si ama Dio (cfr. 1 Gv 4,20). In effetti, la persona che non ama, che non si dona generosamente, non conosce veramente Dio, e non lo conoscerà mai perché, come dice San Giovanni, «Dio è Amore» (1 Gv 4,8.16).
Chi non sa amare non entrerà mai nella “frequenza” del Dio di Gesù Cristo; non ci sarà alcuna connessione, non ci sarà, come si suol dire, feeling, sentimento. E il problema è questo: se l’amore non “decolla” nella vita di una persona, prima o poi entrerà in questo “circolo vizioso” segnato dall’individualismo, dall’isolamento e dalla tristezza. In qualche modo si può dire che chi non ama muore, o almeno muore in parte: diventa come uno zombi, assente, sbalordito, stordito, ridotto nella sua umanità.
2. Alcune difficoltà nell’avventura dell’amore
I filosofi stoici, che fiorirono durante i tre secoli che precedettero l’epoca di Cristo, lottarono positivamente per convincere la gente a non amare e, ancora di più, a non cercare di essere amati. Si sono resi conto di un dato di fatto: che l’amore produce spesso noia e sofferenza (soprattutto quando viene rifiutato). E l’uomo, che vuole essere felice, non dovrebbe cercare la sofferenza. Al contrario! Però così finisce per non amare. Nei confronti della vita cerca d’eliminare le passioni, per produrre ciò che gli stoici chiamavano apatheia, indifferenza verso il mondo e verso gli altri. Tuttavia, l’amare non si limita alla pura donazione, alla generosità senza ulteriori indugi.
Chi ama vuole necessariamente ricevere, essere riconosciuto, apprezzato, amato. Vuole essere ben voluto. Persino Dio stesso cerca la risposta dell’uomo quando lo crea e lo salva. In lingua latina ci sono due parole diverse per esprimere questa idea: amare e redamare, amare ed essere amati. Sarebbe impossibile per l’uomo vivere e amare senza essere amato, dare senza ricevere, impegnarsi senza essere riconosciuto. Siamo fatti così; riceviamo più di quanto diamo. Il cristiano che sa di essere una creatura di Dio lo apprezza perfettamente.
Rispettare il tempo nella sessualità e nell’amore
Il problema comincia comunque quando le persone non sono disposte a rispettare i tempi e la realtà concreta dell’amore, e pretendono di essere riconosciuti e amati immediatamente, senza soluzione di continuità, senza aspettare. Cercano una gratificazione immediata per il loro “investimento” affettivo. Ecco perché il desiderio di essere amato e riconosciuto dagli altri, d’altra parte naturale, ha bisogno di essere educato o disciplinato. Se le persone cercano di ricevere un bonus grande il prima possibile. . . prima o poi vedranno come le relazioni con gli altri si deterioreranno.
Prima si diventa incapace di amare chi ha bisogno, colui che in quel momento non è in grado di rispondere o semplicemente non vuole rispondere. E poi smetteranno di amare gli altri completamente. Avranno cura solo delle amicizie che interessano, saranno facilmente offesi, smetteranno rapidamente di donarsi agli altri, diventeranno perennemente infelici e infedeli, incolperanno gli altri.
Capacità di amare con maturità ed essere amato
Per i cristiani sarebbe particolarmente grave se si verificasse questo fenomeno. Se il cristiano non è capace di amare con maturità e perseveranza, senza ricevere continuamente gratificazioni che possono legittimamente essere pretese solo da bambini o da malati, perderanno il sale e la luce, la capacità di rendere visibile l’amore generoso e paziente di Dio, presente nel cuore con la virtù infusa della carità. Ameranno esclusivamente alcune persone. . . soltanto coloro a cui sono sicuri di piacere e che li ricompenseranno immediatamente per i loro sforzi. Gli episodi biblici che parlano del
maltrattamento che Gesù Cristo ha promesso ai suoi – ad esempio, quando ha detto che bisogna porgere l’altra guancia (cfr. Mt 5,39) – potrebbero essere interpretati come segni di debolezza, di poca forza umana. Ma in realtà sono un chiaro segno di fortezza in persone capaci di sopportare pazientemente la sofferenza, l’incomprensione, il dolore, la premiazione differita. Diranno: «Il Signore è il mio pastore; non manco di nulla» (Sal 23,1). In effetti, al cristiano viene chiesto di avere una pelle spessa o dura, almeno occasionalmente.
3. La chiave dell’amore
Vediamo così che la chiave dell’amore risiede nella capacità di gestire bene la dinamica della gratificazione immediata, e in particolare, di come differirla. Negli anni ’60 il prof. Walter Mischel, della Stanford University degli Stati Uniti, ha fatto un esperimento che è diventato noto, il cosiddetto “esperimento marshmallow”. Mischel diede questi dolci morbidi e gommosi, molto apprezzati dai piccoli, a un gruppo di bambini separatamente, tutti di quattro anni circa. Lasciò poi davanti a loro un altro dolce, spiegando che avrebbero potuto prenderlo se volevano ma che se avessero aspettato 20 minuti senza prenderlo, ne avrebbero ricevuti altri due. Il dilemma per i bambini era notevole: prendere subito le caramelle, o aspettare per averne di più?
Molti riuscirono ad aspettare, altri no. Lo stesso professore Mischel seguì queste persone per molti anni e scoprì che quelli che erano riusciti ad aspettare alla tenera età di quattro anni, riuscirono poi ad aspettare anche più tardi godendo di una vita più fortunata: un lavoro meglio pagato, un matrimonio più stabile, più amici e interessi, meno problemi con l’alcol, la droga e la sessualità.
E non dovrebbe sorprendere che le cose siano così: in effetti, coloro che sanno vivere senza cercare la gratificazione che è loro dovuta sapranno come gestire la vita in modo migliore, sapranno investire con saggezza i loro talenti e le loro energie, aspettando risultati migliori.
Il tossicodipendente non sa attendere la gratificazione
Al contrario, le persone che non sanno come differire la gratificazione che corrisponde alle loro azioni finiscono per avere problemi e difficoltà in molti campi, in particolare quelli che si riferiscono ai sensi, alle passioni, alla sensibilità umana, agli affetti, ai sentimenti. Spesso si trovano trascinati dai capricci delle loro inclinazioni e desideri, che vanno e vengono, che sorgono e scompaiono, si intensificano e poi svaniscono. Non sono veramente liberi – anche se hanno la sensazione passeggera di esserlo –, ma più o meno schiavi, dipendenti. Non sono felici, o meglio, lo sono di tanto in tanto, in modo effimero. . . La verità è che non trovano soddisfazioni profonde e durature.
È quasi inevitabile che in determinate circostanze queste persone cerchino “compensazioni” narcisistiche e insensibili di ogni tipo: sessuale, abuso di sostanze, maltrattamento di persone, ecc.
4. Una dinamica di gratificazione differita nel vero amore
La domanda è questa: come convincere la gente a sapere “investire” generosamente e con costanza nella vita delle altre persone, amando sinceramente e fedelmente? Anche se hanno l’impressione (temporanea) di «sprecare il loro aroma nell’aria del deserto»[1], come dice il poeta inglese Thomas Gray. In inglese si dice spesso “forgive and forget”, cioè “è conveniente perdonare e poi dimenticare”. Ma forse quello che va al cuore della questione è poter dire “give and forget”, cioè “conviene dare e poi dimenticare”. . . : amare generosamente, magnanimamente, senza cercare di dettare i tempi e le modalità della risposta che è desiderata e vogliamo che venga soddisfatta. Così le parole di San Giovanni della Croce, «dove non c’è amore, metti amore e otterrai l’amore»[2].
Quelli che non contano troppo il costo dell’amore, quelli che si danno a titolo gratuito, non dominati dal piacere immediato di essere amati ma dai reali bisogni di coloro che li circondano, saranno ricompensati al di là di tutti i loro sogni. Ma ciò si farà nei tempi di Dio, quando Dio vorrà e come Dio vorrà. Bisogna imparare a lasciare andare le redini dell’amore, smettere di cercare di calcolare gli atti e gli effetti. Colui che premia è Dio, anche attraverso altre persone. Questa è l’avventura dell’amore!
L’avventura dell’amore nelle Scritture
Due testi della Sacra Scrittura, tra gli altri, parlano di questa dinamica. Per prima, nel Salmo 127,5-6, al seminatore viene detto:
«Chi semina con lacrime mieterà nella gioia». E poi: «Nell’andare, se va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni».
Il seminatore soffre e piange sperimentando e ricordando il lavoro faticoso di dover spargere il seme. Non vede il frutto, il risultato. Piuttosto lo aspetta. Il seme muore; non esiste più. Sembra scomparire sulla terra. Ma i mesi passano, arrivano le piogge, il freddo e il sole. I semi nascosti sotto la terra densa, dura e scura cominciano a germogliare, a cercare la luce.
A poco a poco appare sul campo una sfumatura verde, appena percettibile, che parla di speranza. E poi arriva il frutto maturo, nutriente, abbondante. . . E ora, dopo mesi di attesa, il seminatore, colui che aveva pianto e sofferto, canta, ride, gode dell’abbondanza del raccolto. Questa è la vita della persona che ama e sa aspettare, senza certezze, senza garanzie. . . ma gode del suo amore più di chiunque altro.
Ricevere il cento per uno da Dio quando si ama
L’altro testo rappresenta una promessa del Signore, che dice:
«Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna» (Mt 19,29). È lo stesso messaggio: chi ama in modo sacrificato riceverà una grande ricompensa da Dio, in questa vita e nella vita eterna. Quello del “cento per uno” appare di nuovo in un testo lucano che parla, come nel Salmo, della messe:
«Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. . . Un’altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò cento volte tanto» (Lc 8,5.8).
Di fatto, l’intero messaggio morale del Nuovo Testamento si concentra sulla promessa futura che premia lo sforzo attuale dei discepoli di Cristo. «Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolatii …, i miti, perché avranno in eredità la terra …, quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati» (Mt 5,4-6). Tutte le beatitudini esprimono lo sforzo, il dolore attuale, vissuto nei confronti del futuro premio. Come abbiamo visto, la Sacra Scrittura non fa altro che promuovere quella che ora chiamiamo una dinamica di gratificazione differita.
5. Educare per godere l’avventura dell’amore
E che cosa possono fare le persone per acquisire l’abitudine di amare disinteressatamente? Come educare per godersi l’avventura dell’amore? Ecco sei suggerimenti.
Il primo: l’importanza di iniziare e perseverare nella preghiera. Dio dà la sua grazia quando vuole, e con essa dà anche una straordinaria capacità di amare “alla maniera divina”, chiamata “carità”. Ma Dio ci chiede lo sforzo di pregare, mentalmente e vocalmente, anche se abbiamo l’impressione di perdere tempo e pensiamo che la nostra preghiera sia inutile, perché nella preghiera si tratta di scoprire non solo la vicinanza e il conforto e la luce di Dio, ma anche la sua alterità, la sua distanza e quindi anche il bisogno di abbandonarci a Lui con fede, senza avere la sicurezza che i nostri sensi – il tatto, l’udito, la vista. . . – ci danno.
Nella preghiera si impara a rinunciare al controllo della nostra situazione e della nostra vita. Ci scopriamo nelle mani di Dio, mani forti e paterne, mani gentili, ma non nostre mani.
Con la fede tutto appare come dono di Dio
In secondo luogo, noi cristiani siamo convinti che tutto, davvero tutto, ciò che abbiamo a nostra disposizione, l’abbiamo ricevuto da Dio. Tutto, talenti e abilità, di natura e di grazia, sono interamente frutto della donazione divina, anche se l’abbiamo ricevuto attraverso altre persone in diversi momenti della vita, anche se l’abbiamo fatto nostro (perché nulla di ciò che abbiamo a disposizione è interamente nostro), anche se l’abbiamo a nostra disposizione.
Per questo motivo, quando offriamo alle altre persone ciò che abbiamo, cioè quando amiamo generosamente, non ha senso congratularci con noi stessi per la nostra apparente magnanimità. Piuttosto l’amore di Dio, che ci riempie con i suoi doni, ci spinge, ci costringe quasi, ad amare, a dare generosamente, senza sentirci tristi quando non siamo riconosciuti ed apprezzati.
Missione apostolica
Quando il Signore comincia ad insegnare ai discepoli ad andare a due a due per preparare il cammino, come racconta l’evangelista Matteo nel capitolo 10, sembra togliere piuttosto che dare loro qualcosa, pone gli ostacoli piuttosto che dare aiuto: «Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone» (Mt 10,9s.). E lo fa con un’espressione che va al cuore stesso del Vangelo, dice: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8).
Avevano ricevuto tutto per puro dono. . . perciò dovevano dare tutto senza mettere alcun tipo di intralcio, senza pensare di fare un grande favore a Dio o all’umanità. Lo stesso atteggiamento si trova altrove nel Vangelo quando il Signore invita i discepoli a rispondere: «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare» (Lc 17,10). In molte occasioni la semplicità e la spontaneità con cui i credenti amano gli altri, li perdona, gli vuole bene, li protegge, li difende, parla bene di loro. . . li porterà a riconoscere che c’è qualcosa di speciale, forse qualcosa di divino nella loro vita, qualcosa di invisibile, una generosità che esce dal normale, il «profumo di Cristo» (2 Cor 2,15).
Generosità degli apostoli
In questo modo si può comprendere l’enigmatica esortazione di Gesù: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,16). Vedendo le buone opere dei cristiani, vissute con generosità, gli altri possono percepire qualcosa di più, qualcosa che va oltre le forze della creatura, e dire, “Qui c’è Dio”, e rendono gloria “al Padre vostro che è nei cieli”. Sant’Agostino ha osservato con la consueta acutezza: «Chi non dona [agli altri] è ingrato verso Colui che lo ha riempito con i suoi doni»[3].
Donare agli altri è un privilegio
Il cristiano è convinto che la possibilità di dare con generosità agli altri è un grande privilegio che Dio ha reso possibile nella sua vita. In termini oggettivi, questa donazione, più che altro, è un atto di accoglienza, di ricezione, perché diamo agli altri ciò che in primo luogo ci ha dato Dio e ce l’ha dato per loro. Si pensa all’uomo ricco del Vangelo le cui terre hanno portato molto frutto (cfr. Lc 12,16-20), egli conserva tutto per sé, senza condividere, chiudendo il suo cuore: «Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni». E dice a se stesso: «Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!».
I beni che abbiamo a nostra disposizione per fatica o per fortuna non sono nostri, ma appartengono a Dio e sono destinati agli altri. In questo senso, il cristiano ama, si dona, con un cuore riconoscente, con uno spirito eucaristico, felice di arricchire l’altro pur non vedendo i risultati, felice perché «accumula tesori in cielo» (Mt 6,20), sicuro nella fede che ha nelle parole del Signore, perché il «Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt 6,6).
Saper chiedere perdono e voler amare
Il terzo suggerimento è il perdono. Qui la vita del cristiano raggiunge il suo punto più alto. Dio, ricco di misericordia, perdona l’uomo che, pur essendo una creatura, e solo una creatura, si ribella contro il suo Creatore. Dio potrebbe schiacciare il peccatore, eliminarlo senza ulteriori indugi. Può sembrare la cosa più giusta, la più appropriata. Dio sta sul punto di farlo in diversi momenti della storia della salvezza. Ma non lo fa. Non condanna il peccatore pentito. Lo perdona, e lo perdona con tutto il cuore, infondendo in lui la propria vita, fino a renderlo suo figlio, figlio per grazia, e quindi erede eterno. «Dio perdona tutto e perdona sempre», ripete spesso Papa Francesco.
E questo straordinario modo di agire di Dio ci spinge, nonostante il desiderio di vendetta che può sorgere nel cuore umano, a perdonare gli altri con tutto il cuore, «settanta volte sette» (Mt 18,22). Senza questa disposizione di fondo da parte del cristiano, il Signore ci ricorda che Dio potrebbe andare così lontano da negarci il suo perdono. «Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe» (Mc 11,25).
Non esagerare i difetti altrui
E questo sforzo di perdonare, di dimenticare, di trascurare un po’, di non esagerare i difetti di altre persone, per trattare bene tutti, qualunque cosa facciano. . . plasma come poche cose il cuore dell’uomo, lo fa crescere, lo rende capace di amare. L’amor proprio che in molte persone si gonfia in modo sproporzionato, viene ridimensionato, debitamente ordinato, situato al suo posto. L’amore proprio acquista una misura ragionevole. . . e le altre persone sono amate, se possibile, con un amore più grande dell’amore naturale che si ha per se stessi.
Il perdonare non è un segno di debolezza. . . anzi, è segno di grandezza. Prima di tutto perché il cristiano crede che Dio premierà (o punirà) le opere buone (o cattive) degli altri. . . e non vuole prendere il posto di Dio in un atto di tale peso. E inoltre perché richiede un grande autocontrollo per evitare che il desiderio di vendetta distorca il processo e finisca per danneggiare l’altro al di là del male che ha inflitto.
La lotta spirituale per maturare nell’avventura dell’amore
Il quarto suggerimento viene dato dalla vita ascetica, il combattimento spirituale. È conveniente che noi uomini trattiamo noi stessi con una certa fermezza, durezza si potrebbe quasi dire, con intolleranza (non verso gli altri, si capisce, ma con i propri capricci). Così nel mangiare, nel bere, nel dormire, in relazione all’ intrattenimento, il comfort, la vista. . . Sono piccole cose, ma ripetute e frequenti, che plasmano il carattere giorno dopo giorno, rafforzano le virtù, indirizzano la volontà per non lasciare che i disagi della vita possano sminuire o amareggiare l’amore, disagi a volte causati dalla gratificazione differita, però disagi che non influenzano troppo le decisioni, non distorcono il giudizio, non tolgono la libertà, non paralizzano l’amore.
Avventura d’amore in Teresa di Calcutta
Madre Teresa di Calcutta ha espresso la sua esperienza: «Ho scoperto il paradosso, che se ami fino a quando non fa male, non c’è dolore, perché c’è solo più amore». Chi ama è capace di soffrire, di sopportare, soprattutto di soffrire per gli altri, in modo che non debbano soffrire così tanto. Così Gesù, poco prima di essere portato alla morte, disse ai suoi carnefici davanti ai discepoli: «Vi ho detto: sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano» (Gv 18,8).
Quinto suggerimento, ciò che abbiamo appena detto vale in particolar modo per la castità, virtù che regola il desiderio sessuale delle persone, che li rende capaci di amare veramente, senza cercare una gratificazione sensuale immediata, disposti ad aspettare, a rispettare i tempi dell’amore.
È sorprendente notare che il filosofo ateo Max Horkheimer, della Scuola di Francoforte, si mostrava favorevole all’enciclica del Beato Papa Paolo VI, Humanae Vitae (1968), in cui si ripete l’insegnamento cristiano sull’illiceità della contraccezione.
In un’intervista nel 1970 gli è stato chiesto: «Non è la pillola [contraccettiva] un segno di progresso, tenendo conto del terzo mondo, dei problemi di sovrappopolazione?». E Horkheimer rispose: «Il mio dovere è quello di ricordare alle persone il prezzo che devono ‘pagare’ per questo processo. Il prezzo da pagare è l’accelerazione della perdita di nostalgia, la nostalgia della persona amata. La dimensione sessuale è sempre presente. Però quanto più grande è la nostalgia dell’unione con la persona amata, più grande diventa l’amore»[4].
Vivere la castità per voler l’avventura dell’amore
Qui si situa il dilemma. Chi non vive la castità, chi ha fretta di godere della gratificazione che viene dall’amore, finirà col non amare. Il vero amore, d’altra parte, sa molto delle attese, della nostalgia, dei tempi lunghi, dei desideri, dei sospiri. Chi si arrende al godimento immediato e sensibile normalmente associato all’amore umano, finirà per conoscere molto poco dell’amore; rimarrà con un cuore piccolo, schiavizzato e narcisistico. Peggio ancora: finirà per conoscere poco della persona che pensa di amare.
E questa dinamica si verifica con ogni tipo di mancanza sessuale: la pornografia, la prostituzione, la masturbazione, la fornicazione, l’adulterio, i rapporti omosessuali, l’uso dei contraccettivi. . . In tutte queste situazioni si smette di amare la persona, facendo di essa un oggetto al servizio dell’auto-gratificazione, strumentalizzandola egoisticamente, amandola come una cosa inanimata.
Si presenta sempre la stessa dinamica, la stessa incapacità impaziente di aspettare, di rispettare i tempi, di accettare i ritmi del corpo umano, della materia, della vita. Forse è per questo che c’è qualcosa di gnostico in tutte le colpe contro la castità, qualcosa che va contro la materia, il tempo, il corpo, qualcosa che nega la risurrezione della carne.
Superare la vita secondo la carne
Come disse Tertulliano a proposito dei gnostici, «Nessuno vive così tanto secondo la carne ma chi nega la risurrezione della carne»[5].
Un poeta inglese del Cinquecento, Francis Davison, riassunse quella situazione con l’espressione «absence makes the heart grow fonder», (l’assenza rende il cuore più affettuoso): l’assenza, cioè, la nostalgia, la separazione dalla persona cara, aumenta l’affetto del cuore. Chi sa aspettare, chi sa rispettare le dinamiche del proprio corpo e dell’altro, ha tutte le possibilità di raggiungere l’amore. Chi cede immediatamente alla ricerca della gratificazione immediata, si svuota, diventa amaro, perduto, incapace di amare.
Bisogno di essere amati
Sesto e ultimo suggerimento. “Ha tutte le possibilità di raggiungere l’amore”, abbiamo appena detto. Perché è anche vero che chiunque aspetta, e aspetta e aspetta. . . potrebbe non trovare mai la ricompensa del suo amore.
Coloro che amano, necessariamente vogliono essere amati, aspettano sempre la loro ricompensa, venga quando venga. E se si deve aspettare troppo a lungo, se non si riesce a suscitare la risposta degli altri, la persona potrebbe perdere ogni speranza di essere amato. Il percorso di negazione, di sacrificio, di rinuncia, non è necessariamente un percorso di realizzazione; con una vita così, una persona può diventare amara, solitaria o decisamente egoista se non sperimenta l’amore.
È vero che Dio non smette di premiare coloro che si sforzano di amare altruisticamente. Ma dobbiamo anche pensare all’importanza del fatto che ci sono persone nella società che semplicemente amano, amano coloro che non sono sempre facili da amare, coloro che si tende a “scartare”, come spesso dice Papa Francesco: gli anziani, i bambini non ancora nati, i malati, i poveri, i brutti, i tossicodipendenti, coloro che conducono una vita disordinata, che non sanno corrispondere. . .
L’amore che muove il sole e tutte le stelle
Per questo forse ci vuole una speciale chiamata di Dio, che dà alle persone una capacità speciale di amare, liberamente, tutti gli uomini. Dante parlava nel Paradiso de «l’amor che move il sole e l’altre stelle»[6]. Dopotutto, Dio è quell’amore. . . ma gli uomini che hanno imparato ad amare sapranno fare qualcosa di simile, “muovere il sole e tutte le stelle”. . . e ancora di più, perché con Dio arricchiranno la vita degli uomini con un amore più grande. Si tratta in effetti di un’avventura d’amore che non finisce mai.
Paul O’Callaghan
Note sul articolo voler aventura dell’amore
[1] T. Gray, Elegy Written in a Country Churchyard.
[2] GIOVANNI DEllA CROCE, Lettera del 6 luglio 1591.
[3] GIOVANNI DEllA CROCE, Lettera del 6 luglio 1591.
[4] M. HORKHEIMER, La nostalgia del totalmente Altro, Queriniana, Brescia 1994, 87s.
[5] TERTUllIANO, De resurrectione, 11, 1.
[6] DANTE, Paradiso, Canto XXXIII, 145.