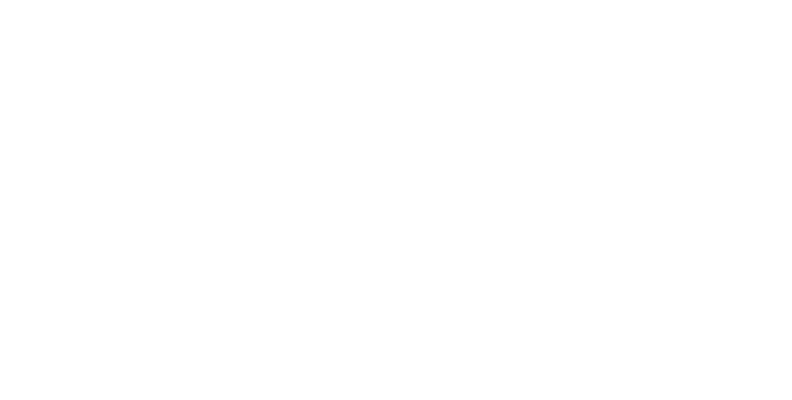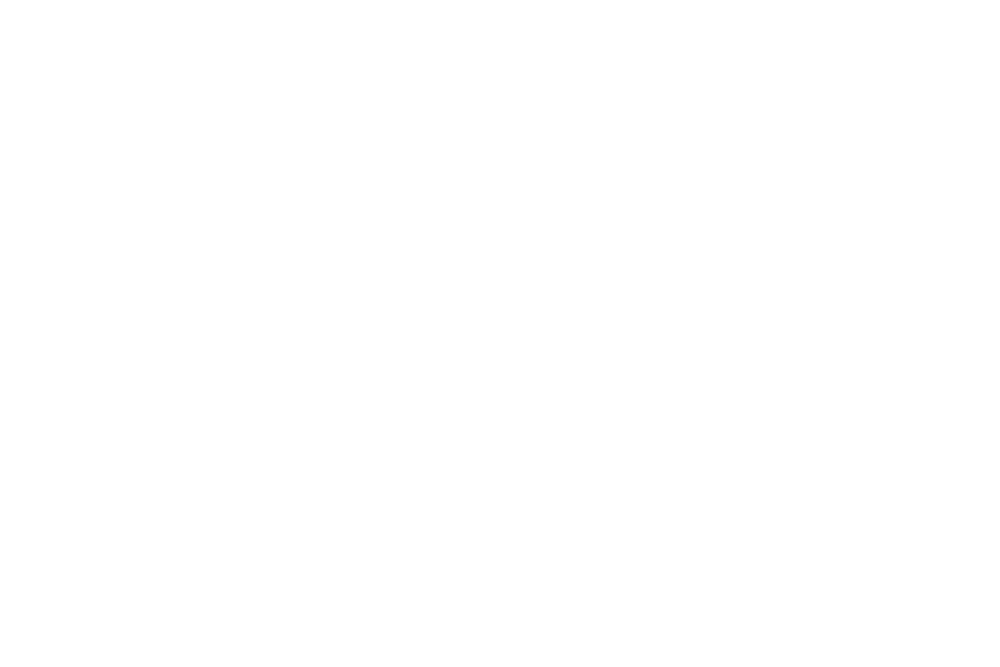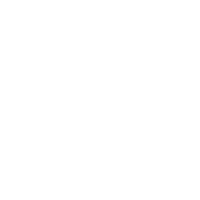Pregare con il Creato
La conversione personale nell’Enciclica Laudato si’
Laudato si’ mi’ Signore. Le prime parole dell’enciclica di Papa Francesco aprono uno splendido orizzonte di speranza.
Il noto canto alla creazione, di Francesco d’Assisi, si rivolge a Qualcuno per i quali non siamo esseri lontani, e che aspetta da noi una risposta, un impegno, un gesto di gratitudine per tanti doni, tra essi il mondo in cui viviamo.
I numeri citati corrispondono ai numeri dell’enciclica.
Pochi giorni fa ho potuto apprezzare un’opera d’arte intitolata Memento (dal latino: ricordati), dipinto da un prestigioso cardiochirurgo romano che ora si dedica alla pittura, Pier Augusto Breccia.
L’immagine impressiona con la sua forza. Le spiegazioni dell’autore l’hanno reso viva. Con la sua gentile autorizzazione, la userò per fornire qualche spunto di riflessione sull’enciclica. La tela, alta più di due metri, raffigura una stanza in prospettiva. Nelle balconate laterali, persone di diverse classi e condizioni, osservano con indifferenza la scena centrale. Due figure indistinte flagellano la sfera del mondo. Appena sopra, attraverso uno squarcio nel tetto appare improvvisamente Gesù Cristo sulla Croce. Uno dei carnefici, con lo sguardo assorto sul Dio fatto uomo, lascia cadere la frusta.
Rompere con l’indifferenza di fronte ai problemi del mondo
Il Papa scrive sulle meraviglie della nostra madre Terra, che «protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei» (2). Questo avviene sotto lo sguardo indifferente dei potenti, dei ricchi, dei corrotti…, di ognuno di noi che, tante volte, dai balconi del potere, della propria comodità o dell’indifferenza non vogliamo complicarci la vita. Per troppo tempo abbiamo trascurato il rischio. È ora di svegliarsi, perché «l’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune» (13).
San Francesco d’Assisi, che «amava ed era amato per la sua gioia e autenticità» (10), ha sconfitto la pigrizia, la comodità, e ha vissuto una vita piena di significato. È necessario cambiare lo stile di vita, essere più solidali. E questo cambiamento potrà essere raggiunto se cambiano «i modelli di produzione e di consumo» (5), ma soprattutto se ogni persona decide di migliorare se stessa, guardando la terra, il cielo e coloro che verranno. Il cristiano non recita Padre mio che sei nei cieli, ma Padre nostro...
Non considera la terra una casa ad uso esclusivo, ma la condivide con tutti gli uomini e le donne, i credenti e i non credenti, con i pesci, gli uccelli, le piante… E invita a cantare «il sole, la luna e gli animali più piccoli» (11), anche alle cose inanimate come rocce e minerali… che sono state create buone. Quanto è grande e ricca la diversità di forme, dimensioni, età, e pensieri! Tutti diversi e tutti guardati con amore dallo stesso Creatore. Dobbiamo porre fine non solo al «rifiuto dei potenti, ma anche al disinteresse degli altri» (14), che siamo tutti noi.
Meravigliarsi come i bambini di fronte alla bellezza e verità
L’enciclica è una chiamata ad aprirsi alla magia del mondo e dei suoi abitanti, per scoprire l’Autore divino. Che bello sarebbe tornare a meravigliarsi come i bambini! Come quel bambino descritto da Chesterton: un giorno, presto la mattina, si avvicina ad una finestra arrampicandosi su una sedia, e guarda il sole che sorge! Signore, lo hai fatto ancora! Esclama. Forse oggi molti giovani, e non tanto giovani, di fronte a uno spettacolo come questo del sole diranno soltanto: ma già l’ho visto sul web, è come un salvaschermo…
La vita è sicuramente più gioiosa quando usciamo al di fuori di noi, quando al posto di tanti click, sappiamo goderci della bellezza vera, della natura off line.
In questo modo possiamo più facilmente rinunciare a «fare della realtà un mero oggetto di uso e di dominio» (11), e «riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla» (12). «La consapevolezza che siamo una sola famiglia umana» (52) ci può svegliare dal nostro torpore, per proteggere l’ambiente e aiutare gli altri.
All’interno della grandezza dell’universo, la più alta causa di meraviglia è l’essere umano, creato ad immagine e somiglianza di Dio, amato da Lui prima della sua formazione nel grembo materno. È una grande fonte di speranza sapere che «siamo stati concepiti nel cuore di Dio» (65). Risuona la voce di sant’Agostino, «gli uomini di solito ammirano l’altezza delle montagne, le grandi onde del mare, le ampie correnti dei fiumi, il vasto oceano, il corso degli astri; ma si dimenticano di quanto possono ammirare in loro stessi» (Confessioni, VIII).
L’uomo, con la sua «capacità di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione con altre persone» e con Dio Padre, ha una dignità infinita (65) che non può dimenticare. E maltrattare altre creature è contrario proprio alla sua stessa dignità (92).
Proteggere i più deboli del mondo
Come il santo di Assisi, «esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole, e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità» (10), dobbiamo difendere i più bisognosi. La terra flagellata, come appare nel quadro, ci porta a pensare ai più deboli. Non possiamo restare in silenzio di fronte alla cultura dello scarto (20-22, 43).
I primi a notare il rigore della frusta che li getta via da questo mondo, sono i nascituri, i malati, i bambini, gli anziani, i lavoratori precari, i senza tetto, gli emigranti in fuga dalle guerre o dalla miseria… Queste persone, con la loro dignità infinita, cadono nel buio cosmico, nel vuoto, a causa di tante leggi fatte solo per i ricchi e per i sani. Quanti politici chiudono le porte della casa comune a quanti sembra che non siano utili.
Nel compito di tutelare i più deboli, i primi su cui volgere la nostra attenzione sono quelli che stanno per nascere. Così si esprime il Papa: «non appare praticabile un cammino educativo per l’accoglienza degli esseri deboli che ci circondano, che a volte sono molesti o importuni, quando non si dà protezione ad un embrione umano benché il suo arrivo sia causa di disagi e difficoltà» (120).
Se siamo in grado di cantare le bellezze del mondo, è perché ci rendiamo conto che «la vita umana stessa è un dono che deve essere protetto da diverse forme di degrado» (5). Questa vita oggi è minacciata e schiacciata da leggi che promuovono l’aborto e la manipolazione genetica senza scrupoli (31).
Ancora una volta i politici sono chiamati in causa. È molto ingiusto e destabilizzante voler escludere qualcuno dalla casa comune, «incolpare l’incremento demografico e non il consumismo estremo e selettivo di alcuni» (50); voler imporre le loro politiche in materia di controllo delle nascite e la cosiddetta salute riproduttiva. Sono gli stessi che promuovono la sessualità senza gli aspetti che la fanno umana, con la pornografia e l’anticipo delle esperienze sessuali. Così fomentano la prostituzione e gli abusi sui minori. Cresce un business enorme, superiore a quello del prodotto interno di molte nazioni: è la danza intorno al maiale d’oro, con le parole di Viktor Frankl.
Il mondo flagellato «include l’ambiente, la vita, la sessualità, la famiglia, le relazioni sociali, e altri aspetti» (6). Una piaga frequente è l’ideologia del gender, che cerca di imporre senza fondamenti scientifici l’assenza di una distinzione tra maschi e femmine. Si tratta di una grave piaga che danneggia l’identità di base di molte persone: ancora una volta i più vulnerabili sono i più deboli: i bambini, costretti a ricevere indottrinamento, senza il consenso dei loro genitori.
Il Papa si riferisce ai cambiamenti sociali allarmanti, «l’esclusione sociale, la disuguaglianza nella disponibilità e nel consumo dell’energia e di altri servizi, la frammentazione sociale, l’aumento della violenza e il sorgere di nuove forme di aggressività sociale, il narcotraffico e il consumo crescente di droga fra i più giovani, e la perdita di identità» (46).
Gli esseri umani hanno una natura comune che devono rispettare e non possono manipolare a piacere (155). Questo è il fondamento di una «fraternità universale» (228). Si deve «accettare il proprio corpo come dono di Dio» (155), rispettando il suo significato. Non si può negare che ci siano differenze tra i sessi, e ridurre tutto a una mera sessualità animale. Dobbiamo capire gli esseri umani «apprezzandoli nella loro mascolinità o femminilità», creati per popolare la terra e godere con rispetto. Anche in questo modo si smette di flagellare il mondo.
La natura umana, patrimonio di tutti, soffre quando si vuole modificare la sua essenza. Questi intenti abusivi sono simili alla spazzatura che ora sommerge «i paesaggi d’altri tempi» (21). Di fronte a questa realtà, dobbiamo ricordare che ciascuno di noi è amato, ciascuno è necessario (65).
L’essere umano non è «pienamente autonomo. La sua libertà si ammala quando si consegna alle forze cieche dell’inconscio, dei bisogni immediati, dell’egoismo, della violenza brutale» (105). È questa una nuova chiamata alla conversione personale. Ad ognuno di noi si chiede la sobrietà nei consumi, dare a coloro che hanno di meno e non aspirare a un sempre più rapido progresso soltanto delle minoranze (193), ad un potere sempre maggiore delle nuove scienze che, se non controllate, si rivolgono contro i più debole, come nei regimi totalitari (104) rivestiti di apparente democrazia.
Prendersi cura della natura sotto lo sguardo di Gesù
Tutto il creato attende la redenzione, che si fermino i colpi di frusta. Aspetta ancora oggi, perché anche se il sacrificio di Cristo è avvenuto una volta sola, è stato per sempre e l’universo continua a beneficiarne. La Croce rimane un avvertimento, un campanello eterno, come nell’immagine che stiamo guardando. La cura della madre terra e della nostra natura umana richiede sforzo, sacrificio, mettere da parte i bisogni egoistici e pensare agli altri.
La conversione e la maturità possono raggiungere un livello cosmico. «Non possiamo sostenere una spiritualità che dimentichi Dio onnipotente e creatore» (75). Dobbiamo vivere con responsabilità: saper rispondere a Colui che si è fatto uomo per noi. «Il destino dell’intera creazione passa attraverso il mistero di Cristo, che è presente fin dall’origine» (99).
Nel corso dei secoli le miserie degli uomini hanno lasciato il segno. «L’ambiente naturale è pieno di ferite prodotte dal nostro comportamento irresponsabile. Anche l’ambiente sociale ha le sue ferite. Ma tutte sono causate in fondo dal medesimo male, cioè dall’idea che non esistano verità indiscutibili che guidino la nostra vita, per cui la libertà umana non ha limiti» (6). Per questo Cristo, la Verità, appare nella storia.
Il rimedio sta nel non dimenticare che «noi stessi siamo terra (cfr. Gen 2, 7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora» (2). Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo rivolgere lo sguardo a Colui per il quale sono state fatte tutte le cose, a Cristo.
Vederlo nella croce e capire che dobbiamo rinunciare a possedere tutto e sodisfare tutte le ambizioni, per un amore più alto. Dobbiamo «passare dal consumo al sacrificio» (9), avere un bella relazione con Dio, con gli altri e con la terra (66). Così si riesce a godere in profondità di ciò che ci circonda; «gli stessi fiori del campo e gli stessi uccelli che Egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua presenza luminosa» (100).
Dio si è fatto uomo, è venuto ad abitare con noi, ha piantato la sua tenda in mezzo a noi (cfr. Ap 21, 3). Dio non è fuori o lontano, ma spezza il cielo ed entra nel nostro mondo. La vastità dell’universo, la fragilità umana, ci portano a «pensare l’insieme come aperto alla trascendenza di Dio» (79). Si tratta di una novità che apre la nostra vita ad un altro, a un Tu (81). È un Dio vicino perché «egli ci ha amati per primo» (1 Gv 4, 19). «Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi» (84).
L’enciclica è rivolta a tutti gli uomini di buona volontà. Guardando in su il cristiano vede Cristo che rivela la verità su se stesso e sul mondo. Il non cristiano e il non credente che cercano sinceramente la verità, che è apertura, scopriranno sufficienti segnali per raggiungere il Creatore. Chi, invece, si chiude su se stesso e non supporta il dialogo, rimane isolato e triste.
È necessaria una conversione personale che ci faccia uscire da noi stessi
«Non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo» (118), che si renda conto che la sua intelligenza lo fa somigliare al creatore e lo avvicina in un modo nuovo ai suoi simili. Se vogliamo trasformare la giungla che ci circonda, dovremo cominciare dal nostro giardino, dall’ecologia della vita quotidiana, che si manifesta «nella nostra stanza, nella nostra casa, nel nostro luogo di lavoro e nel nostro quartiere» (147).
E i valori fondamentali provengono dalla famiglia, dove si impara ad accogliere e proteggere la vita come un dono di Dio. Si impara pure «a chiedere permesso senza prepotenza, a dire “grazie” come espressione di sentito apprezzamento per le cose che riceviamo (…), e a chiedere scusa quando facciamo qualcosa di male» (213).
La conversione personale richiede la grazia divina, la recezione dei sacramenti che scaturiscono dalla Croce di Cristo. Nei sacramenti vediamo in modo privilegiato «la natura assunta da Dio e trasformata» (235). E al centro di tutti i sacramenti, troviamo la presenza reale di Cristo «nell’Eucaristia (dove) il creato trova la sua maggiore elevazione» (236). È un’altra manifestazione di come il Figlio di Dio non appare «dall’alto, ma da dentro» (236). L’Eucaristia è «il centro vitale dell’universo», «unisce il cielo e la terra».
Non poteva mancare un riferimento a chi ci ottiene tante grazie di conversione, a Maria, la Madre del Redentore. Lei è la «Regina di tutto il creato» (241). Il Papa finisce la sua lettera con un capitolo intitolato Al di là del sole. «Alla fine ci incontreremo faccia a faccia con l’infinita bellezza di Dio» (243). Chi guarda Dio fatto uomo, come uno dei due tormentatori del quadro, è in grado di lasciare le fruste, di vivere il potere come servizio, di accogliere tutti, soprattutto i più deboli. Soltanto così può maturare come persona.
Chi guarda Gesù, lascia la massa informe e in lui appare un volto: un volto forse spaventato e ancora incredulo, ma in procinto di convertirsi. Memento homo… Ricordati uomo e donna di cosa sei fatto, qual è il tuo destino, la tua missione e la tua grandezza. E continua a ripetere Laudato si’ mi’ Signore.
Wenceslao Vial